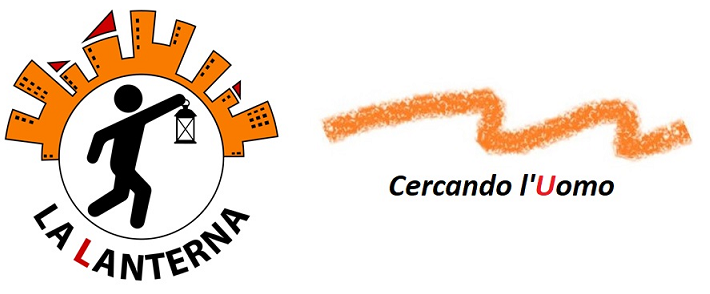I social ormai fanno parte delle nostre vite ed è difficile immaginarci senza. Questi sono nati con lo scopo di renderci più vicini agli altri e “accorciare le distanze”, ma anche di condividere con gli amici ciò che stiamo facendo. Col tempo però sono cambiati: se fino a qualche anno fa non ci preoccupavamo di postare foto mosse perché volevamo solo avere il ricordo di una bella serata passata con gli amici, oggi è importante “non rovinare il feed”, postare foto “belle” perché devono essere viste da tutti. Foto “belle”. Ma chi decide esattamente cosa è bello e cosa no?
In più, viviamo in una società in cui è più importante condividere sui social cosa stiamo facendo, piuttosto che viversi il momento; è più importante apparire che essere. Viviamo nell’idea di doverci omologare e assomigliare tutti, perdendo la nostra autenticità, perché ciò che è diverso fa paura. Penso che il filosofo tedesco Martin Heidegger avrebbe definito tutto questo come “dittatura del Si”. Egli è vissuto nel Novecento e non ha assistito all’avvento dei social, ma vedendo come affronta il tema dell’inautenticità nella sua opera magistrale “Essere e tempo” (1° ediz. 1927)[1] penso che se vivesse oggi farebbe delle considerazioni in merito. In questo testo, Heidegger non si esprime in chiave moralistica: in parole semplici, per lui non è importante stabilire cosa sia lecito fare e cosa no; ma analizza tutti i modi di essere dell’uomo, tra cui appunto l’inautenticità, per capire l’uomo nella sua interezza.
Si parla di inautenticità nel momento in cui definisco me stesso solo in base a ciò che posso fare di ‘uguale’ o ‘diverso’ dall’altro, poiché non vivrò più secondo i miei desideri ma solo in base a ciò che la società mi impone. Cado così nel “Si” impersonale, ovvero quella dimensione neutra e inautentica in cui vengono annullate le peculiarità di ognuno. Può essere un concetto difficile da comprendere però proviamo a fare un esempio nella nostra contemporaneità: io vorrei pubblicare sui social una foto perché mi piace tanto, anche se è non è perfetta ed è venuta male, però non lo faccio perché se lo facessi verrei vista dagli altri negativamente. È come se ci fosse una “regola” implicita che dice che non “si” possono postare foto brutte. In questo modo noi viviamo la quotidianità mettendo al centro ciò che è accessibile a tutti nella dimensione pubblica e perdiamo così la singolarità di ognuno di noi. Viviamo nella “medietà”, nella “norma”: si fa così perché è consuetudine e non puoi fare ciò che tu vuoi, si fa perché si deve fare e non perché io effettivamente voglio farlo. Nessuno è veramente sé stesso e vige l’omologazione. Come possiamo vedere, il discorso di Heidegger si può attualizzare alla perfezione nel contesto dei social, in cui perdiamo la nostra autenticità solo perché “si” deve apparire in un certo modo e “si” devono fare le cose in un certo modo.
Per il filosofo, sono diverse le modalità in cui viene perpetuata questa inautenticità. Per esempio, con la “chiacchiera”[2], cioè un discorso effimero, che ha perso il contatto con la verità, la cui forma prevale sul contenuto. Ciò che conta è che si discorra, piuttosto che comprendere il significato delle parole. E così, l’infondatezza della chiacchera ne favorisce la diffusione pubblica. Un altro esempio è la “curiosità”[3] di vedere il mondo nel suo apparire, senza approfondirlo nella sua autenticità. La curiosità non è quindi stupore poiché ci rende incapaci di concentrarci. Dalla chiacchiera e dalla curiosità consegue infine l’”equivoco”[4]: tutto sembra compreso, ma non lo è, e, nonostante ciò, anche i più incompetenti parlano.
Questa è per il filosofo una condizione in cui siamo gettati e da cui non possiamo uscire. Siamo tranquillizzati dall’idea di vivere nel “si” impersonale perché facciamo ciò che fanno tutti senza riflettere, né pensare. C’è tuttavia una luce in fondo al tunnel: Heidegger ci dice che l’inautenticità è un nostro modo di essere nel mondo, ma in realtà noi siamo stati creati per vivere nell’autenticità. Solo il semplice fatto di riconoscere il nostro modo di essere inautentici è un campanello che ci invita ad aprirci verso l’autenticità. I social non sono autentici, ma solo il fatto di riconoscerli come tali dovrebbe farci rendere conto delle possibilità più autentiche che possiamo viverci nel mondo reale. Mentre il “si” impersonale ci imprigiona, la scelta individuale ci permette di scegliere noi stessi e di liberarci da una condizione inautentica. Decidere di vivere di più nel mondo reale significa percorrere la “strada meno battuta”, riappropriandoci della nostra autenticità, quella che Heidegger chiama “eigentlichkeit” (che letteralmente significa “essere più propriamente noi stessi”). Solo in questo modo diventiamo più fedeli al nostro stesso essere, anziché dipendere dalle aspettative altrui.
[1] Heidegger M., “Essere e tempo”, (edizione a cura di Chiodi, Volpi), Longanesi, 2023. Paragrafo 27 (pag.157)
[2] Paragrafo 35 (pag. 206)
[3] Paragrafo 36 (pag. 209)
[4] Paragrafo 37 (pag.212)