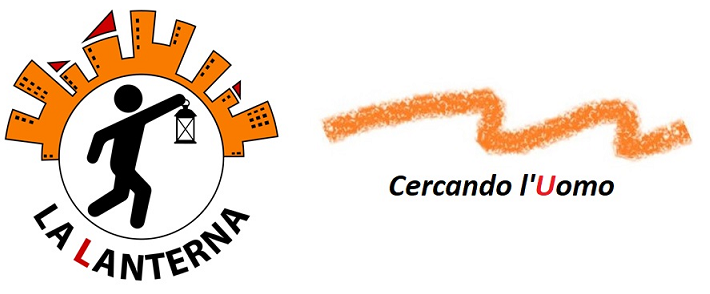“Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. (…) Considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice “molti uomini hanno vita di quieta disperazione”, non vi rassegnate a questo. Ribellatevi! Non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno!”
Queste sono le parole pronunciate dal professor Keating, interpretato da un geniale Robin Williams, nel film “L’attimo fuggente” (1989) nella celebre scena in cui sale in piedi sulla cattedra e si rivolge alla classe. Chiunque abbia visto quel film, sicuramente sarà rimasto folgorato da quella scena poiché non è affatto comune vedere un professore di liceo atteggiarsi in quel modo. Ma è proprio questo ciò che stupisce di Keating nel film: con una modalità sicuramente non convenzionale, cerca di convincere i ragazzi a mettere sempre in discussione le proprie idee, senza essere pigri mentalmente. Questo non è mai una cosa negativa, anzi come direbbe Platone “il filosofo non sa, ma è consapevole del suo non sapere, e perciò desidera la conoscenza. (Al contrario, colui che non ritiene di essere bisognoso, non desidera ciò di cui non ritiene aver bisogno.)” [Platone, Simposio, 204 A].
Da un punto di vista psicologico, chi crede di possedere la conoscenza ha una tendenza a prendere per vero quello che desidererebbe fosse tale e difficilmente crederebbe a tutte quelle idee che sono contrarie alle sue speranze e desideri. Questo fenomeno è noto come “bias di conferma”. Lo psicologo israeliano Daniel Kahneman ne parla in “Pensieri lenti e veloci” (2012). Egli distingue due sistemi mentali: il sistema 1(fast thinking) e il sistema 2 (slow thinking). Il primo è veloce, automatico e impulsivo e, per questo, tende a commettere errori di valutazione e bias; il secondo, invece, è lento, analitico e razionale ed è più vigile rispetto all’altro. Quando il sistema 2, che avrebbe il compito di dubitare, è pigro, il sistema 1 è sprovveduto e tende a credere a tutto. Si incappa così nel bias di conferma poiché il sistema 1 compie giudizi affrettati e fallaci, formulati senza spirito critico. A livello neurale si tratta di una condizione di “rigidità cognitiva” perché il nostro cervello si crea un sistema di dogmi a cui aderisce fedelmente, non accetta altri punti di vista diversi dal proprio, ha paura dell’ignoto, trae conclusioni partendo da informazioni sbagliate e/o parziali, semplifica i pensieri. Inoltre, effettuiamo una lettura della realtà semplicemente binaria, senza percepirne la complessità e le sfumature di significato.
Come uscirne? L’obiettivo sarebbe quello di sviluppare la creatività, ovvero una nuova postura interiore che permetta di superare la condizione di rigidità e favorisca invece la “plasticità cerebrale”. Sin dall’infanzia dobbiamo essere “abituati a pensare” e ciò è possibile solo tramite un metodo educativo che favorisca un pensiero riflessivo e critico. È ciò che il filosofo-pedagogista John Dewey teorizza in “Come pensiamo” (1910): questa modalità di insegnamento innovativo dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo di un buon metodo di studio, piuttosto che sull’accumulo passivo di nozioni, e sull’equilibrio tra la sperimentazione e la diligenza. Solo così si promuove il pensiero critico, che per Dewey si basa a tutti gli effetti sul metodo scientifico poiché permette di verificare la veridicità delle nostre credenze su una base solida di evidenza e razionalità. Mettere in dubbio i propri dogmi significa, infatti, stimolare la curiosità, che ci permette di estendere il campo dell’esperienza e di conoscere cose nuove. La nostra visione del mondo non è oggettiva, quindi decostruire le nostre certezze e accogliere il dubbio ci induce a non essere superficiali e a osservare la complessità della realtà.
Educare i ragazzi al pensiero critico e riflessivo significa permetter loro di pensare con la propria testa, senza farsi condizionare dall’esterno. Questo conduce alla libertà e significa avere il coraggio di andare controcorrente, perseguendo i propri ideali. Pensare è un atto di resistenza e ribellione contro quei dogmi che ci vengono imposti dall’alto. Come direbbe George Orwell in “1984” (1949), anche quando la menzogna, come ad esempio “2+2=5”, viene spacciata per verità e le masse iniziano a crederci, bisogna avere l’audacia di dubitare, anche se ci si sente soli. In fondo, “Libertà è libertà di dire che due più due fa quattro. Stabilito questo, tutto il resto è un corollario”.