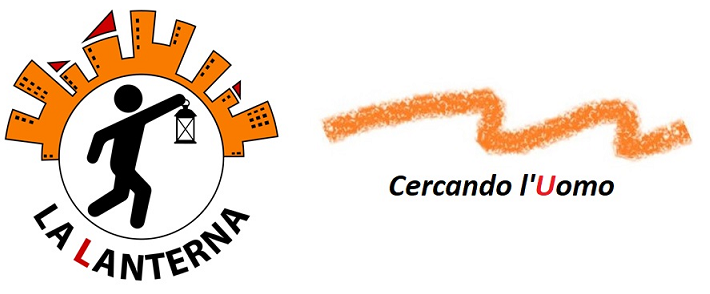Sin dall’infanzia veniamo educati alla pace e tendiamo a considerare la guerra come qualcosa di negativo, che dobbiamo evitare a tutti i costi. Eppure, oggigiorno sembra quasi la normalità parlare di guerre. Quando accendiamo la tv e vediamo il telegiornale ci imbattiamo in immagini atroci provenienti da Gaza: è l’inferno in terra, dove gli assassini agiscono impunemente e i civili diventano “scudi umani”.
In questo contesto diventa, secondo me, attualissimo il pensiero della filosofa novecentesca Hannah Arendt, che ha a lungo analizzato il fenomeno dei totalitarismi e in particolar modo il nazismo. Ne “L’origine dei totalitarismi” (1951) Arendt analizza con cura le condizioni storiche, sociali ed economiche che hanno portato all’ascesa del regime nazista e si interroga su come si è potuti arrivare alla creazione dei campi di sterminio. Per la filosofa, il dominio totale di questo tipo di regimi ha come scopo quello di distruggere l’unicità e la diversità degli individui e oggettificarli, rendendoli tutti “corpi uguali”. Nei campi, però, questi corpi sono morti viventi, a cui viene innanzitutto negata la facoltà giuridica, poi quella morale e infine vengono annullati proprio come persone in quanto tali. Così, anche la morte diventa anonima.
Sembra quasi di descrivere la situazione che c’è oggi nella Striscia di Gaza. Davanti a tutto questo scempio ci sentiamo impotenti perché siamo abituati a credere che coloro che perpetuano queste atrocità siano sempre persone lontane da noi, delle eccezioni; in poche parole, dei “mostri”. In realtà quelle persone carnefici non sono “eccezioni” come noi pensiamo, ma sono persone normali come noi, calate in un preciso contesto sociale.
Sempre Hannah Arendt in un’altra opera intitolata “La banalità del male” (1963) riporta fedelmente il processo a Otto Adolf Eichmann, comandante delle SS, considerato uno dei responsabili della cosiddetta “soluzione finale” degli ebrei. Per Arendt l’individuo definisce sé stesso solamente nella sfera pubblica e politica, luogo in cui siamo tenuti a rispettare certi obblighi morali collettivi, come ad esempio il rispetto interpersonale. Tuttavia, può capitare di sottrarsi a questo tipo di responsabilità non per cattiveria, ma per “dimenticanza”. Eichmann non viene descritto dalla filosofa come un’eccezione, ma come un individuo mediocre, dallo scarso pensiero critico, obbediente agli ordini del Reich. Quindi è la mancanza di riflessione sul proprio agire, nonché la cieca obbedienza agli ordini, che conduce al male banale, inconsapevole, ma non meno atroce di quello volontario. Eichmann ha dunque agito passivamente, senza rendersi conto di quello che stava facendo, così come tutti i nazisti. (L’obbedienza passiva all’autorità è stato un tema analizzato anche dal punto di vista psicologico. Ad esempio, Stanley Milgram, col suo noto esperimento del 1961 svoltosi a Yale, negli Stati Uniti, dimostrò che gli uomini subordinati agli ordini possono essere indotti a compiere azioni contrarie alle proprie convinzioni etiche.)
La scarsa capacità di pensiero critico può dunque essere letale in ambito sociale. L’intento di Hannah Arendt è stato far comprendere ai propri lettori che il fenomeno dell’Olocausto è sì un frutto della società di massa del Novecento, ma potrebbe ripresentarsi in un altro momento sotto altre spoglie. Il male banale si intreccia profondamente con l’inconsapevolezza di chi lo perpetua, che si limita ad un silenzio apparentemente innocuo ma che con facilità sfocia in assenso. Si diventa così spettatori passivi che si abituano alle atrocità e le normalizzano.
L’obiettivo oggi è riflettere su questi temi delicati, soprattutto fuori dall’ambito accademico, e comprendere in primis il perché nella storia siano successi tragici eventi, ma battersi affinché tutto questo non accada mai più. Studiare il passato non serve solo per ricordare certi drammi, ma serve anche per riconoscerli nella contemporaneità. Non serve a niente studiare l’Olocausto se oggi non ammettiamo che a Gaza è in corso una distruzione a senso unico e che bisogna fermarla il prima possibile.
Concludo riportando due citazioni profondamente attuali di due grandi autori del Novecento.
“È avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire” Primo Levi
“E voi imparate che occorre vedere e non guardare in aria, occorre agire e non parlare. Questo mostro stava una volta per governare il mondo! I popoli lo spensero ma ora non cantiamo vittoria troppo presto. Il grembo da cui nacque è ancora fecondo.” Bertold Brecht